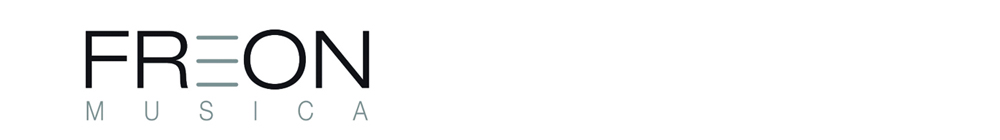Rust never sleeps.
Neil Young
E siamo fatti per ritornare (nella nostra interezza
priva di differenze, di cuciture visibili alla vista,
al tatto) senza pensieri sui nostri passi, respingendo
la dolcezza delle città ignare, filiali, che lasciano
pure noi fendere le mura, frugare i segreti.
Fingiamo che il latte degli stranieri sia versato
per noi pure. Nostro il pudore dei larghi androni,
del verde osteso a perdita, di confini sconosciuti
ai polpastrelli ignoranti, ciechi della promessa
di spazi non misurabili a patto delle pareti-cielo.
Essere separati e vicini le domeniche a Milano
come scoiattoli che custodiscono i gherigli a morte.
Polpa che non vuole essere frutto, colluttazione
tra Heimat e fabbrica, tra lievito e ruggine,
cospargendo di saliva le pietre del selciato.
Così è nostro il ritorno non greve, vergognoso
di ricontare gli aghi, tracciare rotte per gli occhi,
annodare fili di ruggine, indossare un abito di risentimento,
indicare alla bocca, ai figli, alle piume delle prigioni
un varco, una faglia a cui appendere un desiderio di stasi.
.
.
L’urna vuota del giorno che dicemmo:
è così per sempre, è un’ambra propulsiva
di ore meridiane, un castello di lucertole
che trascinano tra le zampe, tra le ombre,
i gridi, il guano delle rondini, particole
di carta e una fuga di acque marroni.
Sotto, una voce a cui non si crede più:
pas la peine d’aller chercher plus loin.
Entrare invece, se un pandemonio di melisse
accorda i nidi dell’orchestra, gli anelli
delle formiche, le pieghe della schiena
quando si torce per dire: riposi il tuo
peso sulle mie vertebre, sulle mie vene,
sui miei polsi, le clavicole, stanca il tuo
cane di ruggine sopra il mio stomaco,
stanca l’onda dei ruggiti, stacca la voce
dalla sua quinta di catrame, trasforma
la fuliggine delle mie ossa in sapone.
Vengano poi gli aratri della palude,
strappino loro i denti agli scorpioni.
.
.
Può fiorire anche la ruggine se un albero è vicino,
se foglie, spighe e cardi spingono e straziano
di una macchina la muscolatura; è questa
propulsione che ricorda allo scheletro teatrale
quando le sue estremità si provavano a toccare.
Qual è la cosa che più amate di questi luoghi
che non conoscete? Quale anemia vi coglie
se intrecciate le mani alla trama screziata
di strade e piazze partorite domani?
Questa città è un nuovissimo sedimento
che non nasconde nulla a gru e scavatrici,
e non trattiene pietre impolverate, collane
ossidate, cucine corrose, lenti sbeccate,
piatti e quaderni, lavatrici e coltelli.
Acqua di palude, germe di malaria.
.
.
Le colline sono declinate in una lingua nuova.
I suoi verbi sono ali bianche che ripetono i nomi
dei dominatori nuovissimi del vento.
Essi non vedono quante ferite sono sparse,
che male sboccia la roccia sulle colline.
Sulle rocce ballano i topi. Da molti anni
conoscono il grigio gramigna che è la base
del pane, le pietre che nutrono i pistacchi,
poi che la sete è la loro balia
e i frutti del deserto sono spicchi asciutti.
Ma il cretto non è deserto, né roccia rossa
permutata in burrone. Eppure tra le sue anse
scivola il fuoco, crepitano i bordi del cemento
sottile, l’acqua sospira, scottano i passi
di quelli che cercano il proprio dolore.
.
.
Costruiscono qualcosa, laggiù, in un luogo
non tracciato sulle mappe: una nave di specchi,
l’ombra di un campanile, un paradiso per i senza
riposo. Nella notte, c’è un respiro che conduce
fuori dal deserto, a casa nel vulcano,
nello spazio che separa ciò che è fragile
da ciò che muore, e lo seppellisce tra il rancore
che asciuga, tra le fotografie che non dicono
chi siamo, ma sciolgono un vento sottile
che acceca il futuro con un pugno di sabbia.
Questa è la casa, un passo di terra scura
inflitto nella sabbia di cui il sapore è scordato.
Quando gli assenti riapriranno gli occhi,
saranno appesi a una quinta di pece
per contrappasso alla noia dei sogni.
.
.